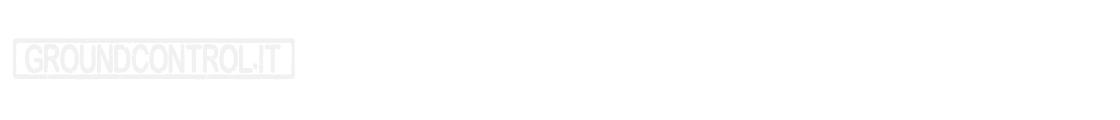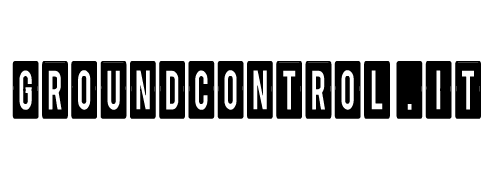Federico Buffa racconta..
No, lungi da me l’intenzione di avvicinarmi anche di un solo centimetro a chi fa del giornalismo sportivo una vera arte illustrativa. L’unica cosa che ci accomuna è l’intenzione di voler dire (scrivere, nel mio caso) la propria versione della storia di uno dei più celebri italiani nel mondo, quantomeno sul piano sportivo.
Non starò a dirvi quali siano le origini, nemmeno a citarvi i suoi successi, chi è interessato sa già tutto a riguardo. Chi non lo è, può farlo in pochi secondi con strumenti come google. Sto parlando, comunque, di Marco Belinelli.
Un ragazzo che, come nei sogni di tanti ragazzi nati e cresciuti nella periferia, si è trovato un giorno con una palla a spicchi in mano a provare goffamente ad emulare gesta leggendarie di campioni altrettanto leggendari. Un ragazzo che, a differenza di tanti, di tutti noi che abbiamo sognato, ce l’ha fatta.
Un ragazzo che, oggi, ha smesso di essere “un italiano in NBA” ed è semplicemente diventato un player NBA in tutto e per tutto. Un ragazzo che, a differenza di molti player NBA, indossa un anello particolare, quello che non molti hanno la fortuna e l’onore di indossare, quello che stelle del calibro di Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley e tanti altri ancora, non hanno mai messo: l’anello di campione NBA.
Marco fa parte della generazione dei primi ragazzi italiani che nel campionato professionistico statunitense hanno iniziato a far parlare di se, come Bargnani, come Gallinari. Di quelli che la lega ha scelta nonostante i precedenti flop di Rusconi ed Esposito. Non è mai stato una stella, ha anzi iniziato nell’assoluto anonimato, nella parte di panchina dimenticata dai coach. Il garbage time, la parte finale della partita, quella in cui gioca chi è fuori dalle rotazioni vere, quando il risultato è già deciso e si cerca solo di valorizzare qualche scalda-panchina per eventuali trade.
Marco inizia dai Golden State Warriors, da Oakland e dal mitico coach Don Nelson che proprio non lo vede. Fa la gavetta, fa la parte di quelli che nemmeno si tolgono la tuta durante la partita, di quelli che sventolano gli asciugamano ai canestri degli altri. Talvolta entra, come detto, nei minuti finali, quando la difesa non esiste più e si passa in fretta da una parte all’altra del campo, con tiri improbabili, azioni 1 vs. 1, una sorta di graduale raffreddamento del match prima che termini.
Ecco, non avrei voluto ma mi sto dilungando sulla sua storia, non avrei voluto ma è difficile evitarlo. La mia attenzione per la sua carriera tuttavia è fatta di altri aspetti, tralascerei ciò che i report di fine gara sanno esprimere con maggiore precisione. Quello che più mi interessa è il suo atteggiamento. Non si scoraggia, nonostante il ruolo ampiamente marginale nel suo team. Non piange lacrime per il fatto di non essere visto ma vive il suo primo anno da studente NBA, tesaurizzando tutto ciò che riesce. Di lì a breve si presenta una seconda occasione. I Raptors dell’amico Andrea Bargnani gli strizzano l’occhio, l’ambiente è molto italian-oriented, oltre Andrea troverebbe Massimo Gherardini che in quel momento è vice presidente della squadra di Toronto e troverebbe persino Bryan Colangelo, GM della squadra, le cui origini mi sembrano piuttosto evidenti. Si sposta, spera di trovare nuova linfa, un minutaggio migliore, un’occasione insomma. E noi lo speriamo assieme a Marco perché in quel momento parte dei nostri sogni si trovano con lui negli Stati Uniti d’America. Anzi no, in Canada ormai, a Toronto.
L’anno non è dei migliori, Marco ha alcune occasioni per mostrarsi ma i Raptors sono una squadra con due grandi difetti. Il primo è quello di trovarsi in Canada e quindi ai margini della grande vetrina NBA. Il secondo è che la franchigia non è sicuramente di quelle che giocheranno i playoff e la regular season è poco indicativa, spesso le partite sono giocate con l’intensità di un buon allenamento e benché questo possa anche tradursi in punti facili, avviene solo sporadicamente. Gli americani sono molto attenti alle statistiche, quelle di Marco non brillano, al contrario di quelle di Andrea. Ma aldilà di questo, sono comunque le statistiche di un player che non ha nemmeno la più lontana prospettiva di giocare i playoff.
Ed è qua che però qualcosa accade. Difatti la stagione, numericamente inferiore anche alla precedente nei Warriors, comunque gli permette di essere al centro di un altro scambio che Marco e la dirigenza dei Raptors accettano, anche perché il ruolo di shooting guard a Toronto ormai è saldamente nelle mani di Demar DeRozan e per lui le prospettive di giocare sono poche.
Giocare poco e farlo persino in una squadra dal record drammaticamente perdente? No, non fa parte del suo progetto ambizioso.
Lo scambio lo porta a New Orleans negli Hornets che si sono trasferiti qua da Charlotte. La squadra è in mano a Chris Paul, talento emergente, probabilmente destinato a diventare a breve la miglior point guard pura della lega. E qua, finalmente, la prima svolta della sua carriera. Lo spot da titolare ma soprattutto la fiducia dei compagni, di CP3 (Chris Paul, per appunto) in particolare.
Marco è finalmente protagonista, la franchigia ha la migliore partenza dalla sua storia e la stagione si chiude con circa 10 punti a partita, quasi 25 minuti di impiego e, udite bene, il 40% dall’arco dei tre punti. Cifre importanti, ma soprattutto l’approdo ai playoff. La carriera di Belinelli pare finalmente bene incanalata, ma nell’estate 2012 avviene l’altra svolta, quella a mio avviso che ha fatto davvero la differenza nella sua storia, ancora più del passaggio agli Spurs con cui vincerà l’anello.
Marco viene ingaggiato dalla franchigia che da piccolo guardava vincere un anello dopo l’altro, trascinati dal più grande giocatore di ogni tempo, Michael Jordan, e la squadra si, sono i Chicago Bulls. Pur di andare a Chicago accetta un contratto ad ingaggio ridotto, segno fortissimo della sua ferrea volontà di lasciare un segno nella lega e non limitarsi a far lasciare un segno della lega nel suo conto bancario.
E’ qui che, sotto la guida di Tom Thibodeau, diventa il giocatore capace poi vincere un titolo. E’ qui che, quando è il suo turno di entrare in campo, realizza letteralmente il sogno di qualsiasi ragazzo italiano che da piccolo va in cortile con un palla a spicchi ed un canestro attaccato al muro. Il sogno è di emulare il più grande di ogni tempo, sua maestà MJ, quello di giocare esattamente al suo posto. Ma è esattamente in questo che Marco non sbaglia niente. Il sogno per lui è ormai tramontato, sostituito da una solida realtà e Marco è perfettamente a conoscenza di non essere nemmeno uno dei lacci che chiudevano le celebri scarpette Nike che a Michael sono state intitolate, le Air Jordan. Non per screditarlo, ci mancherebbe. Ma persino lui mi concederà di pensare che Michael è di un altro pianeta, rispetto a tutti, non solo a lui. Marco è comunque pienamente cosciente di chi è e sa da dove viene. Non dimentica di essere Marco Belinelli nato a San Giovanni Persiceto. E non è per prenderlo in giro sulla particolarità del nome del paese di origine che lo sottolineo, ma piuttosto perché lui sa bene da dove proviene e sa quanto sudore, quante delusioni, quanta fatica e quante rinunce fanno parte del prezzo che ha pagato per la maglia che oggi può indossare. Lo fa egregiamente, giocando come farebbe Marco Belinelli. In questo eccelle ed eccellerà ancora, con questa sua espressione che ad alcuni pare a tratti un po’ buffa e che non cambia mai indipendentemente dal punteggio. Con la faccia tosta di chi, a pochi secondi dalla sirena, non ha alcuna paura a tirare da distanze proibitive.
A volte va male, il più delle volte. Ma quando l’espressione della faccia tosta che fino a quel momento non era mai cambiata, lo fa, è perché la palla è entrata. E allora si scatenano gli highlights, si scatenano le voci del pubblico, la vittoria diventa tua e tu sei l’eroe della notte, una memorabile notte.
A Chicago impara ancora, si perfeziona, difende e conclude come non mai, è la sua laurea di giocatore NBA. Marco, nell’anno che per i Bulls ha visto l’assenza della stella Derrick Rose, passa per la prima volta il primo turno dei playoff e nonostante i report dicano che i compagni di questa avventura, Gallinari e Bargnani, numericamente siano quasi delle all-star, è lui il primo italiano a farlo. Egoisticamente avrei voluto che fosse rimasto qua, è la mia squadra da sempre e la sua presenza avrebbe incarnato alla perfezione il compimento del mio sogno. D’accordo, diciamo un buon sostitutivo del vero compimento. Ma così non è stato e per sua fortuna, soprattutto. Ho detto fortuna si, riflettendoci però la fortuna nel suo caso c’entra veramente poco.
E’ da queste due svolte nella sua carriera che è nato il Marco Belinelli poi diventato campione NBA con gli Spurs di San Antonio. Primo italiano a farlo, non credo che ci sia necessità di dirlo. Anche unico per adesso. E’ per queste scelte che Marco poi ha avuto il miglior record a livello di lega per percentuale di tiro da 3 (primo italiano ad averlo, ma và?). O vincere una competizione piuttosto pubblicizzata come la gara di tiro dell’All Star Game. Il primo, ovvio. L’unico, altrettanto ovvio.
Delle stagioni agli Spurs e dell’anello mi piace citare solo il fatto che chiunque sia rimasto sorpreso di come si sia perfettamente integrato da subito nel sistema di gioco Spurs, il più bello ma anche il più difficile della lega. O l’entusiasmo che un coach leggenda come Popovich esprime verso di lui.
Oggi finalmente raccoglie i frutti delle sue scelte. Dopo gli Spurs Belinelli è passato ai Kings di Sacramento, non una contender per il titolo ma squadra ambiziosa e con tanto potenziale. Compagni come Cousins (che quest’anno è diventato una vera ira di dio in campo), Gay, o il leader in campo Rajon Rondo, possono significare altre vittorie ed altre grandi gratificazioni. Certo, l’anello forse no. Ma ormai il suo è già al dito e nessuno potrà togliergli il fatto che quando lo ha fatto lui, nessuno prima lo avesse fatto mai.
Numericamente chiunque potrà superarlo, ma per il fatto di essere il primo no, nessuno mai.
E c’è una parte di me che talvolta si emoziona al pensiero di questo ragazzo un pò buffo di San Giovanni in Persiceto, con quel suo viso simpatico che ricorda un po’ il giovane Stallone, che ha realizzato ”il sogno”, quello che in molti avevamo e che forse, con lui, un po’ abbiamo realizzato anche noi.
David